Nel capolavoro di Elio Petri, “Indagine su in cittadino al di sopra di ogni sospetto”, Gian Maria Volontè interpreta il Dottore, il commissario di polizia che nell’assumere il comando della sezione politica della Questura di Roma espone le linee di indirizzo della sua attività. Il popolo è espressamente qualificato come minorenne, la repressione come missione è manifestazione di civiltà, la repressione come medicina è il vaccino contro la criminalità, politica o comune che sia.
Perché ricordare quel capolavoro parlando di giustizia? Perché la politica ancora oggi pare convinta che il diritto penale non possa esser che repressivo e che la repressione sia l’unico mezzo per affrontare i reati.
L’attuale indirizzo del governo italiano conferma questa sensazione, in chiara e costante contrapposizione agli indirizzi di una politica liberale in materia.
L’alternativa ad un modello liberale del diritto penale è quella rappresentata dalle varie forme che ha assunto il modello inquisitorio. Parlo di pluralità di forme perché non esiste più l’unitario modello inquisitorio invalso a partire dal dodicesimo e tredicesimo secolo, il modello approntato dalla Chiesa quando questa decise di far propria una politica penale contro gli eretici, con la legittimazione del sospetto, i tormenti per sollecitare la confessione, la delazione e tutti i tristi ed inumani complementi.
Oggi i modelli inquisitori o, se si preferisce, antigarantisti, esistono ancora ogniqualvolta si abbraccino le teorie della prevenzione sociale o della difesa sociale, o si individui, per punire, non il fatto materiale bensì il tipo normativo dell’autore del reato, facendo propria una delle tante possibili varianti eticistiche, antropologiche, decisionistiche o efficientistiche.
L’assunzione a modello di ciascuna di queste possibili varianti è resa ancor più semplice nella misura in cui la vittima del preteso fatto di reato diventa l’eroe moderno[1]. Avviene quindi che le aspettative della vittima diventino, per usare le parole di Filippo Sgubbi[2], fonte di responsabilità penale. L’urlo delle vittime “vogliamo giustizia” tende a far assimilare, del tutto indebitamente, la ragione di giustizia quale risoluzione imparziale di un conflitto e ragione di parte, quale soddisfacimento unilaterale del personale interesse.
Si tratta della attualizzazione, a livello normativo, del modello di capro espiatorio enunciato da Réné Girard. Quando insorgono – o ancor peggio: quando vengono alimentate – ragioni di paura ed insicurezza, un sentimento d’odio si diffonde e permea la società e tende a convergere verso una vittima. Questa è tenuta a pagare non perché sia particolarmente colpevole, ma perché la comunità non è in grado di trovare accordo se non unendosi contro qualcuno.
Questa breve premessa aiuta a comprendere l’ispirazione generale del cosiddetto Disegno di Legge Sicurezza, approvato a settembre dalla Camera dei Deputati ed ora all’esame del Senato della Repubblica.
L’intero impianto di tale disegno di legge è ispirato, con forza e coerenza che avrebbero meritato altro scopo, ad una logica esclusivamente repressiva.
Si dirà: giocoforza essendo un provvedimento in materia penale.
In un sistema penale già gravato da sanzioni penali che spiccano per la severità sanzionatoria, legato del modello valoriale che ispirò il Codice Rocco, il legislatore oggi ritiene che quell’impianto debba esser lardellato con, da un lato, la creazione di nuove ipotesi di reato e, dall’altro lato, inasprendo le sanzioni per alcuni fatti già previsti e puniti come reato.
Nulla di nuovo, si tratta del vecchio mantra del legislatore penale che vanta secolare applicazione: consenso o repressione.
La genesi di un simile intervento sarebbe rinvenibile nell’allarme sociale che le cronache registrerebbero. Da qui la domanda sociale di un intervento, quale che sia.
E’ la classica risposta attribuita alla funzione simbolico espressiva della normazione penale, esempio evidente di populismo applicato al diritto penale. Già vista all’opera troppe volte per poter dire di esser stupiti. Il suo meccanismo è tanto semplice quanto tecnicamente rozzo: si parte sempre da qualche fatto di cronaca, opportunamente veicolato dagli organi di informazione sempre attentissimi a stringere l’angolo della inquadratura in cerca della suggestione che solo la pornografia del dolore o della disperazione sanno descrivere con magnificazione voyeuristica del dettaglio. Da qui la volontà di fornire qualche risposta, per dimostrare che questa volta la politica non è sorda o cieca. E così si appronta per le stampe sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo provvedimento che, ovviamente, non si cura di rimediare alle cause ma si concentra sulle conseguenze. Non si cura la febbre, si comprano nuove pezze per la fronte e nuovi termometri e si aprono più facilmente le corsie di quel surrogato degli ospedali sociali che son le carceri, per chi vi deve entrare, e si serrano le stesse porte in uscita per chi potrebbe uscirne.
Di quel che avviene all’interno degli istituti di pena tanto interessa poco o punto a nessuno, con buona pace della tendenziale rieducazione o risocializzazione del condannato.
Nella ridda di nuove creazioni normative – frutto di autentica incontinenza – vi è l’imbarazzo della scelta. Una cosa è certa: si è nel pieno di quel modello antigarantista di cui si diceva in apertura.
Le misure approntate spaziano dalla creazione pura e semplice di nuovi reati per condotte già di per sé sanzionabili secondo il vigente Codice Penale, tutte caratterizzate da pene edittali severe, all’ulteriore inasprimento di reati già previsti: quest’ultimo caso è quello, ad esempio, che inasprisce le pene per il reato di accattonaggio qualora venga fatto ricorso a minori per questuare. Va detto che tali ipotesi di reato, già introdotte nel 2009 ed inasprite nel 2018 e sempre in pieno sacrale ossequio della funzione simbolico espressiva della normazione penale, non avrebbero di per sé meritato un trattamento sanzionatorio al di fuori dei casi di violenza o minaccia nei confronti di minori.
Si arriva, poi, al paradosso della pretesa stretta sui blocchi stradali. Si tratta di fornire risposta, a quanto pare, all’allarme sociale (del tutto sproporzionato) derivante da chi manifesta per strada. Ora ammesso e non concesso che vi fosse necessità di un simile intervento, la legislazione vigente già sanziona in via amministrativa tali condotte con il pagamento di un importo da euro 1.000 ad euro 4.000. E cosa fa il legislatore? Introduce un reato ad hoc sanzionato con un mese di carcere ed una multa di euro 300. La trasformazione da sanzione amministrativa a reato imponendo, tra l’altro, il ricorso ad un processo per l’accertamento della responsabilità.
Ora, posto che le voci che vorrebbero, per ragioni umanitarie e tecniche, una riforma del sistema penale in modo di dotarci, dopo quasi cento anni di vigore del codice fascista, di un codice di impronta liberale e conforme ai mutati (non oggi, ma nel 1948) principi costituzionali, suonano sorde alle orecchie di governo e maggioranza (e pure di buona parte delle opposizioni) e nemmeno gli argomenti di tipo latamente utilitaristico paiono subire miglior accoglimento.
Uno dei principi ispiratori di un moderno sistema penale dovrebbe esser rappresentato a limitare l’intervento della sanzione penale a quei casi in cui la condotta vietata sia rispettosa del cosiddetto principio di offensività. Detto altrimenti: la condotta oggetto di sanzione deve caratterizzarsi per l’adeguatezza della sanzione rispetto al grado di lesione dei beni giuridici protetti dal sistema, la cui principale griglia dovrebbe esser individuata in primis all’interno dei beni tutelati dalla Costituzione. Come già osservato, il vigente sistema penale, modellato dal Codice Rocco e quindi dalla griglia di beni giuridici da tutelare propria dell’ordinamento che lo aveva promulgato, è caratterizzato da una almeno triplice inflazione dei “beni” penalmente protetti. Si è avuta, infatti, un’espansione della quantità degli interessi tutelati penalmente: da un lato tramite l’incremento, al tempo in funzione evidentemente autoritaria, dei reati senza danno, come quelli che offendono entità astratte come la personalità dello stato o la moralità pubblica o simili. Dall’altro lato attraverso l’aumento incontrollato dei reati consistenti spesso in illeciti di mera disobbedienza. A tale approccio ha fatto il paio, in piena coerenza con lo spirito repressivo ed autoritario di quel modello di codificazione, l’estensione indeterministica del campo di denotazione dei beni tutelati, tramite il ricorso a termini vaghi, imprecisi o ancor peggio valutativi che costituiscono una chiara e deliberata deroga al principio di stretta legalità favorendo in via interpretativa ed applicativa ampi margini di discrezionalità giudiziaria: per fare semplici esempi, basti pensare ai vari reati associativi ed alle figure di pericolosità sociale.

Infine, si è praticata una costante e crescente anticipazione della tutela dei beni, mediante il ricorso alla configurazione di reati di pericolo astratto o presunto contrassegnati dal carattere altamente ipotetico e financo improbabile dell’evento lesivo, tramite il ricorso a formule aperte e non tassative che descrivono l’azione: si pensi al ricorso a formule come “atti preparatori” o “diretti a” o “idonei a mettere in pericolo”[3].
Il ddl sicurezza palesa la propria fedeltà rispetto alla tecnica legislativa che è già presente nel Codice Rocco, in evidente antitesi rispetto ai paradigmi di una legislazione penale liberale.
Si pensi alla proposta di introduzione di una nuova ipotesi di reato antiterrorismo che punisce la detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La scelta descrittiva della fattispecie così come proposta rappresenta, infatti, un chiaro esempio di marcata retrocessione della punibilità in grado di dare rilevanza a tipologie di autore, piuttosto che a fatti connotati, seppure in una dimensione di anticipazione della tutela, da una dimensione di pericolo astratto. Chiara la scelta di fedeltà tecnica del legislatore d’oggi rispetto a quello del 1930 ed altrettanto chiara la sottovalutazione del profilo della offensività della condotta, anche sulla scorta di quanto già segnalato dalla giurisprudenza di cassazione (Cass. Pen., n. 47479/2015) secondo la quale è necessario che in tali fattispecie sia assicurata la specifica offensività dei comportamenti terroristici tramite l’ancoraggio sul piano oggettivo ad un pericolo concreto e non meramente astratto o incentrato sul profilo meramente soggettivo del possibile responsabile.
Il superamento del principio di offensività può esser ottenuto anche mediante diversa tecnica legislativa, cioè non solo e non necessariamente mediante la costruzione di fattispecie disancorate da una quale bene giuridico concreto da tutelare. E’ il caso della proposta, contenuta nel ddl sicurezza in commento, che estende l’applicazione del Testo Unico in materia di stupefacenti anche alla cannabis light, nella parte in cui vieta l’importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, la spedizione e la consegna delle inflorescenze della canapa coltivata, anche in forma semilavorata, nonché tramite prodotti che la contengano. Tale divieto viene supportato dalla riespansione delle norme penali sanzionatorie del Testo Unico.
Qui la componente ideologico-repressiva è palesemente evidente. E si dimostra cieca rispetto ad una realtà carceraria che vede quasi un terzo dei detenuti costretti perché condannati in forza delle disposizioni del Testo Unico e della politica proibizionista che questo persegue dal 1990. Ma oltre ad esser cieco rispetto all’impianto originario della legislazione proibizionista in materia di stupefacenti, il legislatore si mostra ottuso rispetto alla diversa esperienza che con riferimento anche ai soli derivati della canapa coltivata è riscontrabile nel corso degli ultimi 9 anni (e detto di passata: quei derivati di canapa coltivata presentano un principio attivo privo di effetti psicoattivi). Ancor peggio, l’attuale indirizzo di politica penale rende del tutto improbabile la realizzazione di politiche alternative in materia di stupefacenti, ovvero politiche che siano capaci di abbandonare il frusto e fallimentare approccio proibizionista e repressivo in favore di un processo di legalizzazione che consentirebbe di godere di ben maggiori benefici. Benefici che non sono solo quelli relativi alla riduzione delle quantità di prodotto consumato ed aumento della qualità dello stesso, ma anche l’abbattimento dei più generali costi della proibizione, inclusi quelli espliciti relativi alla applicazione delle leggi punitive, nonché quelli impliciti, come il costo-opportunità dei tribunali e delle prigioni (riduzione del numero di processi e riduzione della popolazione penitenziaria), nonché della riduzione della criminalità e della corruzione derivanti dall’esistenza del divieto[4].
Si è detto poco sopra che se le istanze di natura umanitaria non sono capaci di trovare ascolto, l’impostazione complessiva del disegno di legge potrebbe forse esser apprezzata facendo ricorso alla pluralità di modelli latamente utilitaristici in grado di giustificare la normazione penale. Si tratta, per farla breve, di quelle considerazioni che tendono a far prevalere una qualche forma, storicamente più o meno secolarizzata, di bene comune, secondo il criterio di massimizzazione del bene protezione della società.
Ma anche facendo ricorso a tali modelli non è detto che si possa trovare una motivata giustificazione del ricorso ad un generalizzato inasprimento delle sanzioni penali quale strumento di deterrenza generale e quindi riduzione dei fatti di criminalità.
Appare, piuttosto, il contrario. Infatti, tra i tanti possibili modelli di analisi della disciplina penale, gli stessi studi di analisi economica del diritto hanno illustrato come la deterrenza efficiente richiede una pena modesta a fronte di un’alta probabilità di punizione[5]. Qui, invece, si fa l’esatto contrario: pena inasprita con minor probabilità di certa punizione.
In termini generali, merita sempre di esser ribadito come l’inasprimento delle pene non costituisce un elemento né utile né necessario per affrontare il crimine.
Se si prende come riferimento, ad esempio, la politica praticata negli Stati Uniti negli anni ’80, emerge come i responsabili di furto spendevano in carcere, se condannati, dalle tre alle quattro volte il tempo previsto per gli stessi fatti in Danimarca[6] o in altri paesi europei. Una delle ragioni di tale più severo atteggiamento riposava nella domanda di pene più severe da parte della opinione pubblica. Secondo il Bureau of Justice Statistics, anno 2000, ancora nel 1994 l’85% degli americani intervistati lamentava il fatto che le Corti non fossero sufficientemente severe nei confronti dei responsabili di crimini.
Tale maggiore severità punitiva non ha mai comportato una riduzione del tasso di criminalità.
E qui entra in gioco il ruolo dell’opinione pubblica rispetto alla classe politica, tema centrale nell’atteggiamento di molta della legislazione penale dell’attuale dicastero.
Negli Stati Uniti la risposta fornita dalla politica alla domanda dell’opinione pubblica di maggiore severità delle sanzioni produce immediatamente un inasprimento delle pene. In Europa, normalmente, tale domanda sociale viene adeguatamente filtrata dalla politica. Anche dove, come nell’Inghilterra degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, si era dato corso ad un generale atteggiamento maggiormente sanzionatorio non si è mai giunti a punire come negli Stati Uniti (e lasciando da parte, ai presenti effetti, i reati per i quali nei singoli stati nordamericani viene ancora prevista la pena capitale).
Questo perché, come è stato opportunamente notato, nei paesi europei esiste(va) una maggiore distanza tra opinione pubblica e classe politica. La struttura gerarchica del governo inglese è un esempio all’interno del quale il partito di governo e l’esecutivo che ne è espressione hanno più vincoli e dove, si badi, anche il sistema giudiziario si presenta con tratti di maggiore deferenza nei confronti del potere legislativo ed esecutivo[7].
Mentre nel modello inglese, quindi, vi sono limiti istituzionali interni alla dinamica tra poteri dello stato, e gioca un ruolo principale, nella legislazione, il ruolo dei tecnici del diritto, nel modello nordamericano si assiste ad un “diverso e più populista, corso politico, stimolato da gruppi di interesse e politici ambiziosi che reagiscono di fronte a crimini altamente pubblicizzati”[8].
Se si calano queste direttrici al modello italiano qui in commento emergono una serie di evidenti aporie e contiguità.
Da un lato l’aporia è rappresentata dal voler recuperare un ruolo principale, nella dialettica tra formanti del sistema giuridico, al parlamento (ed all’esecutivo che da questo viene supportato) rispetto al potere giudiziario, visto come una alta burocrazia tecnica, con vene fortemente ideologizzate, e privo quindi di legittimazione democratica. Su un piano operativo questa aporia viene risolta mutuando l’atteggiamento nordamericano di inasprimento delle sanzioni tipico di un modello in cui il formante guida è quello giudiziario e in cui maggiore è la torsione populista nella risposta al crimine.
Dall’altro lato, e venendo ai profili di contiguità rispetto al modello maggiormente populista, si assiste in Italia all’emersione del parlamento (e dell’esecutivo) quale interprete diretto della preoccupazione popolare per i fatti criminali, cui tende a rispondere tramite una costante inflazione normativa, tutta di segno repressivo, con poco o punto attenzione alla funzionalità di tale misure di inasprimento sanzionatorio rispetto sia alle cause della criminalità sia alle conseguenze di tali misure repressive. Ne risulta una legislazione di stampo fortemente emotivo, suggestionata più dal timore di perder consenso che dalla capacità di governare il fenomeno.
Ma non basta.
La torsione repressiva si manifesta in tutta la sua inutile e gratuita vessatorietà in altre due previsioni manifesto, quelle relative al reato di nuovo conio che puniscono la rivolta in carcere e, all’interno della fattispecie, pure la condotta passiva di chi resista, pacificamente, agli ordini impartiti all’interno dell’istituto di detenzione.
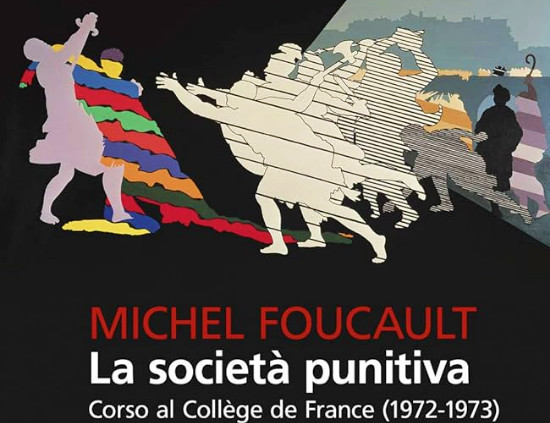
Si deve alla riflessione di Michel Foucault[9] la consapevolezza che la trasformazione della penalità avvenuta con le “moderne” (sic!) istituzioni penitenziarie non riguarda solo una storia di corpi (quelli dei detenuti) ma più precisamente una storia di rapporti tra il potere politico e quei corpi. Ed è la storia, evidente a chiunque abbia visto un carcere al suo interno, della coercizione operata su quei corpi, il loro controllo, il loro assoggettamento, la maniera in cui questo potere viene esercitato direttamente o indirettamente su di essi, la maniera in cui li piega, li fissa, li utilizza. Viene quindi alimentata anche una nuova fisica dell’istituzione penitenziaria in relazione ai custoditi. In questa fisica la delinquenza certo gioca un ruolo fondamentale. Ma, correttamente osserva Foucault, non si tratta di delinquenti, intesi quali mutanti o devianti sociali sui quali si indirizzerebbe la repressione penale. La delinquenza che diviene determinante è quella rappresentata dal binomio indissolubile penalità-delinquente. L’istituzione carceraria fabbrica una categoria di individui che creano un circuito con la stessa istituzione, circuito che si autoalimenta: la prigione non corregge, piuttosto richiama a sé ed incessantemente gli stessi individui. Contribuisce, in questo modo, alla creazione di una popolazione emarginata tramite la quale ci si serve per obiettivi altri: al fondo per far pressione sulle irregolarità e sugli illegalismi che si ritiene di non poter tollerare.
Ed ecco che in un simile contesto, e solo in un simile contesto, si spiega la nuova previsione volta ad incriminare chi, all’interno di un carcere perché detenuto, si renda responsabile di atti di resistenza passiva che impediscano il compimento di asseriti atti d’ufficio necessari alla gestione del carcere. Si incrimina una condotta – la mera resistenza passiva – che si dimostra del tutto priva di qualsiasi capacità di mettere a rischio un bene giuridico – presupposto indefettibile di qualsiasi sanzione penale. Un comportamento innocuo anche perché risulta del tutto privo di qualsiasi ancoraggio costituzionale. Anche in tale ipotesi, quindi, emerge non solo l’evanescenza della condotta, ma anche l’incondizionata volontà di far prevalere il mero rispetto dell’autorità anche a fronte di condotte di per sé del tutto innocue, come il caso della semplice resistenza passiva. Come detto: palese carenza di offensività del fatto che si vuol perseguire.
Questo aborto normativo viene inserito all’interno di un più ampio contesto, quello che, con il disegno di legge, mira a punire gli atti di rivolta in carcere.
Detto altrimenti, e sempre seguendo lo schema tipico del populismo penale secondo cui al fatto di cronaca segue pedissequo ed ottuso l’intervento punitivo bollato e vidimato dal legislatore, poiché le condizioni delle carceri sono notoriamente infami (a luglio scorso, durante l’ondata di caldo che rendeva la vita negli istituiti di detenzione ulteriormente indegna, vi furono rivolte dei detenuti), nulla si fa per renderle meno indegne e chi si trova al suo interno deve accettare di buon grado, in ordine militare, la condizione subumana cui è tenuto.
Si dirà che questo impianto risponde ad esigenze retribuzioniste: ti comporti in modo illecito e paghi per la tua condotta.
Nemmeno questo è vero. La tradizione della Scuola classica del diritto penale, di cui uno dei capostipiti fu Francesco Carrara, e che era scuola di chiara matrice liberale, aveva ben chiaro un principio fondamentale. Il carcere non deve né convertire il detenuto né corromperlo.
La moderna scuola repressiva di cui è imbevuto il provvedimento in commento per certo prova a convertire il detenuto, e non potrà riuscirvi perché capace solo di ulteriormente corromperlo.
Ed è quindi inevitabile chiudere con una amara constatazione sulla qualità dei giuristi che assecondano simili approcci. Ancora una volta, infatti, si deve dar atto delle ragioni di Alexis de Tocqueville, secondo il quale “a fianco di un despota che comanda, si trova quasi sempre un giurista che legalizza e dà sistema alla volontà arbitraria del primo […]. Colui che ha solo l’esperienza del principe, senza quella del giurista, non conosce che una parte della tirannia. Bisogna riferirsi ad entrambe per capire il tutto”[10].
Sarebbe compito di chi coltiva la cultura giuridica e, sommamente, di chi lo fa ispirandosi a principi liberali opporsi a simili interventi normativi e resistere a tale deriva.
[1] C. Eliacheff e D.S. Lariviere, Il tempo delle vittime, Milano, 2008, 17.
[2] F. Sgubbi, Il diritto penale totale, Bologna, 2019, 31.
[3] Sul punto le insuperate pagine di L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 1989, 477-478.
[4] M. Thorntorn, L’economia della proibizione, Macerata, 2009, 223
[5] R. Cooter – T. Ulen, Law and Economics, 4th ed., Pearson, 2004, 474
[6] R. A. Kagan, Adversarial Legalism. The American Way of Law, Cambridge (Mass.), 2001, 68.
[7] J. Q. Wilson, Criminal Justice in England and America, in The Public Interest (Winter), 3 ss., 81.
[8] R. A. Kagan, Adversarial Legalism. The American Way of Law, Cambridge (Mass.), 2001, 69.
[9] M. Foucault, La società punitive, Corso al Collège de France (1972-1973), Milano, 2019, 277 e passim.
[10] A. de Tocqueville, Fragments historiques sur la revolution francaise, Paris, 1865.
Fonte immagine copertina: imagoeconomica.it
© Riproduzione riservata














