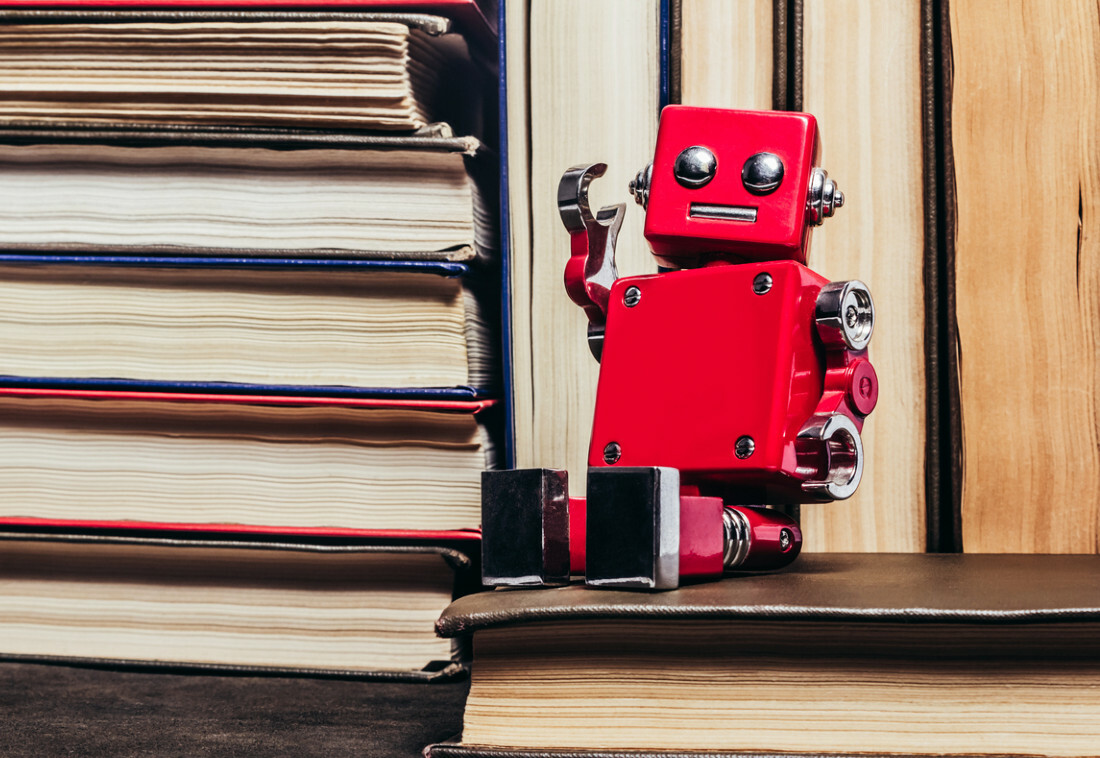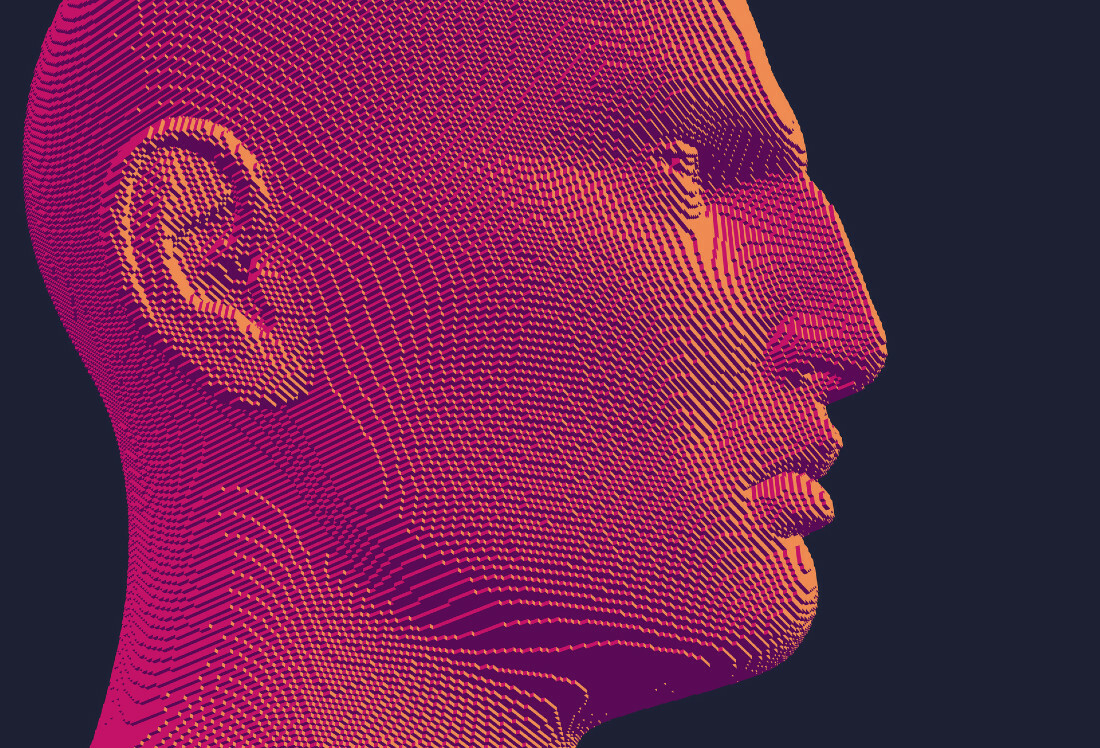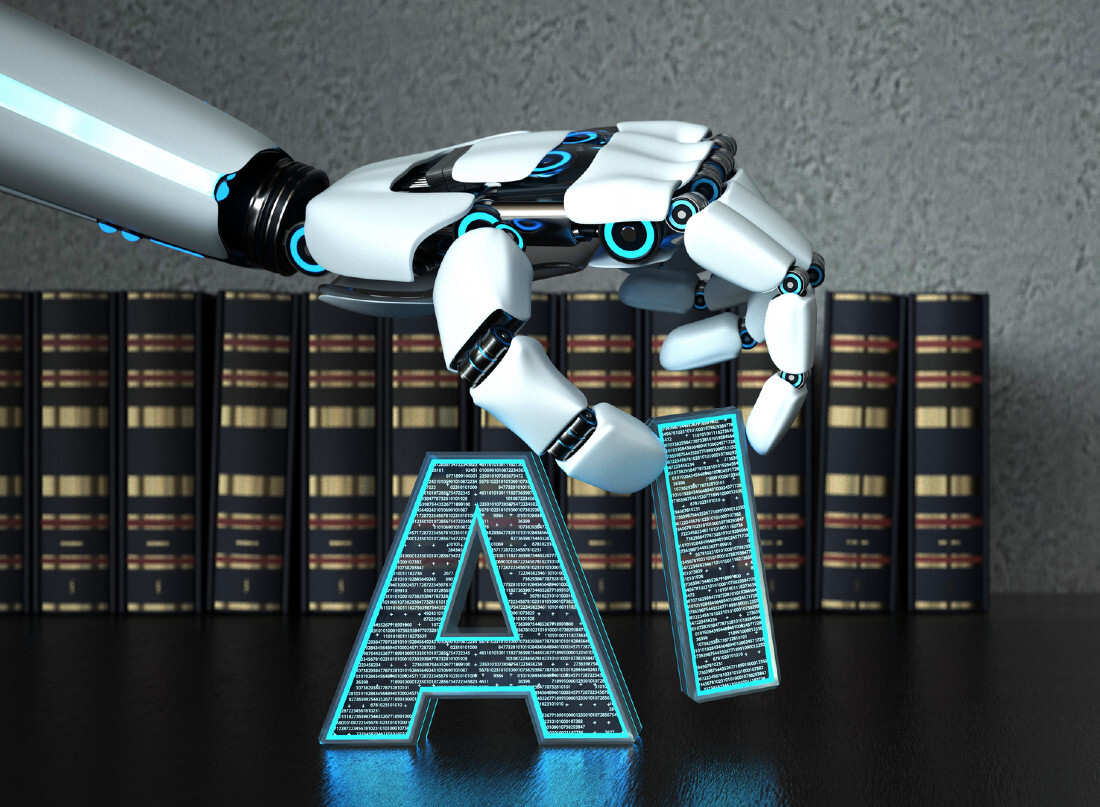Gli investimenti del PNRR del nostro paese in capo al Ministero della Cultura mirano a diversi obiettivi, tra cui il miglioramento dell’attrattività dei piccoli borghi, il rilancio del comparto cinematografico e creativo, la transizione verde e digitale del settore e molto altro. Quantificando in cifre, 500 milioni dei complessivi 4.205 miliardi di euro di titolarità del MiC sono stati destinati alle strategie e alle piattaforme di trasformazione digitale del patrimonio, tuttavia nessuna linea di investimento è stata specificatamente dedicata all’IA.
Nel 2021, quando è stato pubblicato il PNRR, l’Intelligenza Artificiale forse non aveva ancora conquistato quel ruolo dirompente e trasversalmente innovativo che ricopre oggi. Di recente, però, l’ICDP-Digital Library ha lanciato tre innovative soluzioni che impiegano proprio l’intelligenza artificiale per rivoluzionare l'accesso al patrimonio culturale italiano. Cat-IA, chatbot sperimentale per il Catalogo generale dei beni culturali, offre percorsi di ricerca personalizzati e aggregazioni tematiche, mentre Alphy facilita la consultazione del portale Alphabetica dell'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico) con ricerche avanzate nei testi digitalizzati e correzione automatica delle citazioni
I.PaC è il più ambizioso: un’infrastruttura che ospita un catalogo di servizi IA per il processamento avanzato di contenuti multimediali, la riconciliazione di dati da fonti diverse attraverso grafi di dominio e il miglioramento della navigazione dei portali tramite intelligenza artificiale generativa. L'iniziativa rappresenta una strategia integrata per superare le sfide di gestione e accessibilità del vasto patrimonio culturale nazionale, trasformando il modo in cui cittadini e ricercatori interagiscono con le risorse digitali della cultura italiana. In questo scenario, l’IA rappresenta uno dei volani più potenti – e al tempo stesso più controversi – di questa trasformazione.
Tre esperimenti che potrebbero essere solo l'inizio di un percorso che coinvolge l’intero ecosistema culturale, con tutti i suoi attori e portatori di interesse. Per comprendere come l’IA generativa venga vissuta dai professionisti della cultura, la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali ha recentemente pubblicato i risultati di una survey nazionale rivolta agli operatori del settore. I dati offrono uno spunto prezioso per riflettere su opportunità e rischi, usi reali e attese future, nell’intersezione tra tecnologia e patrimonio.
L’IA nel settore culturale: dove e come si applica
L’intelligenza artificiale è ormai entrata a far parte dell’ecosistema culturale con un numero crescente di progetti, sperimentazioni e iniziative – spesso di natura pilota – che cercano di potenziare, semplificare o ripensare le modalità di fruizione, conservazione e gestione del patrimonio. Basti pensare all’utilizzo pionieristico di IBM Watson alla Pinacoteca di San Paolo nel 2017, uno dei primi esempi noti di integrazione di IA in un museo, per comprendere come la spinta all’innovazione tecnologica sia attiva da tempo, pur se in modo disomogeneo.
Uno studio della Commissione Europea del 2022 (“Opportunities and challenges of artificial intelligence technologies for the cultural and creative sectors”) individua tre principali ambiti di applicazione dell’IA nel settore museale e del patrimonio:
1. Archiviazione, catalogazione e gestione delle informazioni
L’IA si sta rivelando uno strumento prezioso per supportare le istituzioni culturali nei processi di digitalizzazione, analisi e accesso al patrimonio documentale. Software come Transkribus AI vengono già impiegati da archivi e musei per l’estrazione automatica di testo da documenti manoscritti o non strutturati, abilitando applicazioni di Natural Language Processing (NLP), come il riconoscimento di entità (named entity recognition), utili per una prima analisi dei contenuti.
Sul fronte della catalogazione automatica, tecnologie di computer vision e algoritmi di machine learning stanno trasformando la classificazione delle collezioni digitali. Tra i musei più all’avanguardia che stanno esplorando questo campo vi sono gli Harvard Art Museums di Boston che sfruttano l’IA per attività di object detection e analisi visiva, automatizzando il riconoscimento degli oggetti e la generazione di metadati e descrizioni.
2. Gestione dei flussi e del management istituzionale
L’adozione dell’intelligenza artificiale si estende anche alla sfera gestionale, con applicazioni rivolte sia all’esperienza del pubblico sia all’organizzazione interna. Alcuni musei stanno sperimentando l’impiego di strumenti predittivi per monitorare e regolare i flussi di visitatori, anticipare i picchi di affluenza e ottimizzare la distribuzione degli spazi. Sistemi intelligenti integrati con sensori ambientali contribuiscono inoltre a garantire il rispetto delle distanze di sicurezza tra il pubblico e le opere, migliorando al contempo la conservazione e la qualità dell’esperienza di visita.
Sul versante interno, l’IA si sta dimostrando utile a incrementare l’efficienza operativa. Strumenti potenziati dall’intelligenza artificiale supportano il personale nella produzione di contenuti, dalla comunicazione digitale (social media, newsletter, sito web) a quella istituzionale o promozionale.
In alcuni casi, l’IA può essere utilizzata per effettuare attività di rilevazione del comportamento dei visitatori: a partire dalla raccolta e analisi di dati relativi alle reazioni e alle traiettorie del pubblico nei percorsi espositivi, è possibile comprendere quali possano essere le strategie più adeguate per accrescere il grado di soddisfazione e poter effettuare eventuali analisi predittive legate alla gestione dei flussi e alla user experience. È il caso del progetto ARTEMISIA sviluppato a Palazzo Braschi da La Sapienza Università di Roma e dall’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR. Si tratta di innovazioni promettenti per il settore culturale, ma che sollevano interrogativi sul rispetto delle normative GDPR. È un ambito ancora sperimentale e non privo di implicazioni etiche, ma che mostra chiaramente il potenziale dell’IA nella raccolta e analisi dei dati legati all’esperienza dei visitatori.
3. Engagement e accessibilità del pubblico
L’intelligenza artificiale ha un impatto positivo sullo sviluppo di nuove modalità di fruizione del patrimonio culturale, permettendo di rendere l’esperienza culturale più personalizzata e quindi più accessibile e inclusiva. Sul fronte dell’accessibilità sensoriale e linguistica, l’IA offre soluzioni promettenti: audio-descrizioni generate automaticamente per visitatori ipovedenti o non vedenti, sistemi di traduzione simultanea multilingua, sottotitolazione automatica di contenuti video e vocali. Un esempio longevo è la collaborazione tra Rijksmuseum e Microsoft che utilizza dal 2019 le potenzialità dell’IA proprio per produrre descrizioni dettagliate per persone non vedenti e ipovedenti. Sul fronte dell’accessibilità culturale e della personalizzazione, i chatbot sono uno strumento sempre più diffuso. Grazie all’IA generativa, questi assistenti virtuali dimostrano di essere capaci di adattarsi al linguaggio, alla curiosità e al livello di conoscenza dell’utente, arricchendo così la visita museale e rendendola più inclusiva, come dimostrano i chatbot realizzati dall’azienda francese Ask Mona per numerose istituzioni museali.
Inoltre, l’IA permette anche modalità di interazione partecipative attraverso strumenti di gamification. Un esempio è il progetto Share your view del Cleveland Museum of Art, che utilizza l’intelligenza artificiale per coinvolgere attivamente i visitatori: questi possono caricare immagini proprie e ricevere in risposta possibili corrispondenze con le opere presenti nelle collezioni del museo, in base al grado di somiglianza tra le immagini.
Oltre l’engagement: la conservazione predittiva e il riconoscimento automatico
Infine, un ambito meno visibile ma in forte sviluppo è quello della diagnostica e conservazione predittiva. Recentemente, durante l’Artificial Intelligence Action Summit di Parigi di febbraio 2025, è stata lanciata l’organizzazione no-profit HeritageWatch.AI per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale combinando intelligenza artificiale ed altre tecnologie per elaborare dati eterogenei provenienti anche da fonti satellitari. Inoltre, l’intelligenza artificiale si sta rivelando uno strumento prezioso anche nel campo della conservazione e del restauro di opere d'arte. Un esempio significativo è il progetto di ricostruzione dei tre capolavori Medicina, Filosofia e Giurisprudenza, commissionate a Gustav Klimt nel 1894 dall’Università di Vienna e andate perdute durante la Seconda guerra mondiale. Di questi dipinti rimangono soltanto fotografie in bianco e nero e articoli della critica dell’epoca. Grazie all’impiego di algoritmi di machine learning e reti neurali, che hanno analizzato le fonti disponibili e studiato in modo computazionale forme e colori delle opere di Klimt, il Belvedere Museum in collaborazione con Google Arts & Culture Lab è riuscito a ricolorare digitalmente i dipinti, restituendo una possibile interpretazione visiva coerente con lo stile dell’artista e i dati storici disponibili.
Come è accolta questa tecnologia dai professionisti della cultura italiani? I risultati della survey di Scuola dei Beni e delle Attività Culturali
Una fonte utile per esplorare come la pensano i professionisti della cultura sul tema è l'indagine "IA generativa e professionisti culturali", condotta nell’autunno del 2024 dalla Scuola Nazionale del patrimonio e delle attività culturali, nell’ambito del progetto “Dicolab. Cultura al digitale” finanziato con il PNRR. I rispondenti sono professionisti esperti (fascia 45-64 anni la più numerosa), altamente specializzati (un terzo dei rispondenti ha master, dottorati o scuole di specializzazione) e distribuiti tra settore pubblico e privato.
Percezioni spontanee: tra riconoscibilità e fiducia
L’indagine si apre con una domanda semplice ma rivelatrice: “Qual è la prima parola che ti viene in mente pensando all'IA generativa?”. Il 10% dei rispondenti ha indicato immediatamente “ChatGPT”, a conferma dell’enorme riconoscibilità del tool di OpenAI, ormai divenuto – almeno nell’immaginario collettivo – sinonimo stesso di intelligenza artificiale generativa. Una dinamica osservata anche nel Regno Unito, dove una survey analoga condotta nel 2023 nel settore del patrimonio culturale ha rilevato un'identica tendenza: ChatGPT era nettamente più noto rispetto a qualsiasi altro strumento.
Ma il dato più interessante emerge dall’analisi della nuvola di parole generata dalle risposte: quasi tutte le parole associate all’IA generativa hanno un significato positivo o neutro. Termini come Supporto, Opportunità, Innovazione, Futuro dominano lo scenario semantico. Le parole con accezione negativa – come Paura o Falso – appaiono marginali e isolate.

Conoscenza e consapevolezza
Quasi la metà degli intervistati (47,8%) dichiara di essere poco informato, mentre solo il 9,7% si considera molto informato e aggiornato. Se confrontato con altri settori, questo dato suggerisce che la transizione all’IA nel mondo della cultura è ancora in una fase iniziale. Tuttavia, va notato che un altro 46,5% ha una buona conoscenza di base: un terreno fertile per avviare percorsi di formazione e sperimentazione.
Il confronto con un recente rapporto BCG, secondo cui solo il 21% dei lavoratori italiani usa l’IA, conferma che la cultura non è isolata, ma parte di una dinamica nazionale più ampia: nel rapporto l’Italia è il penultimo paese per tasso di adozione nelle task lavorative su 48 paesi riportati. Dalla survey rivolta ai soli professionisti della cultura, solo il 15,7% degli intervistati utilizza regolarmente l’IA nel proprio lavoro, mentre il 40,6% non la usa ma si dice interessato a provarla. C’è quindi un potenziale di adozione significativo, ma ancora inespresso.
Per capire a che punto di consapevolezza siano le organizzazioni culturali purtroppo bisogna notare che il 46,3% dei rispondenti dichiara che nella propria organizzazione raramente si parla di AI generativa e nessuno la usa. Solo un'esigua minoranza di enti (6,7%) ha già avviato progettualità concrete. Questo dato mette in luce un vuoto strategico e organizzativo: la cultura dell’innovazione si sta diffondendo più tra i singoli che nelle istituzioni nel loro complesso.

La maggior parte degli intervistati si aspetta che l’IA entrerà “naturalmente, attraverso strumenti tecnologici” (34,4%) o “lentamente, grazie a iniziative individuali” (30,7%). Solo il 17% crede in una vera e propria pianificazione dall’alto. Questo suggerisce una mancanza di leadership strategica e una forte frammentazione tra livelli decisionali.



© Riproduzione riservata